- Categoria: Ricerche a scuola
- Scritto da Angela Maria Granara
Dislessia evolutiva e comportamento aggressivo
Article Index
Gli studi sui Disturbi dell’Apprendimento, sono ancora ad uno stadio di ricerca. Per questo, a tutt’oggi, varie e differenti, sono le ipotesi che intendono spiegare sia l’eziologia di tali disturbi, sia le eventuali conseguenze che da essi derivano. La dislessia evolutiva è il disturbo specifico dell’apprendimento, più studiato.
E’ stato stimato che al 5% della popolazione mondiale (DSM-IV), appartenga questa difficoltà dell’apprendimento, vale a dire che almeno un bambino in ogni classe di ciascuna scuola, necessiti di aiuto per superare queste difficoltà e progredire nelle attività educative.
Vari autori ne hanno affrontato, le cause, i sottotipi, i criteri diagnostici, ma limitato spazio è stato invece dato, all’aspetto comportamentale e riabilitativo correlato a questo disturbo dell’apprendimento, sebbene in letteratura, si rileva che più dell’80% dei bambini con disturbi dell’apprendimento, presentano problemi sociali (Hazel, Schumaker, 1988).
Pochi a tutt’oggi, tuttavia, sono i ricercatori che hanno svolto indagini in questo settore.
Ackerman e Dykman, fondamentali per le loro ricerche in questo campo, dimostrarono che i disturbi più comuni che si sovrappongono ai DSA, sono disturbi comportamentali e di opposizione, affermando che nel 50% dei casi, i soggetti dislessici presentano anche un disturbo del comportamento.
Le cause di questa correlazione sono state studiate secondo visioni diverse nel tempo.
Come sottolineato da Rutter et al. nel 1970, ci sono tre possibilità:
-
La dislessia è causata dal comportamento aggressivo.
Per cui il bambino all’entrata a scuola, già possiede quei disturbi comportamentali che impediranno l’acquisizione delle normali abilità di lettura.Questa ipotesi predirebbe che la delinquenza più tardiva, possa essere una conseguenza della continuazione del comportamento antisociale dell’adolescenza, piuttosto che della difficoltà di lettura di per se stessa. -
Il comportamento aggressivo è una conseguenza della dislessia.
Si inseriscono in questa visione le teorie che appartengono all’approccio basato sul concetto di frustrazione di Dollard e Miller. Questo approccio in opposizione alla teoria di matrice freudiana dell’aggressività come istinto primario, sostiene un rapporto di causa-effetto tra frustrazione e aggressività.Perciò, essendo la dislessia fonte di frustrazioni notevoli in classe e nel gruppo sociale di appartenenza, l’aggressività è ad essa correlata come effetto (Fattori, 1985). - Dislessia e aggressività procedono parallelamente. Sarebbero, dunque correlate, senza che la prima sia subordinata alla seconda o viceversa.
Esisterebbe, sostengono alcuni studiosi, un terzo fattore come uno svantaggio socioculturale che causi entrambe; oppure, suppongono altri (Gilger e collaboratori, 1992), può esistere un’eziologia genetica condivisa, o un sottotipo patologicamente congiunto, mediato geneticamente.
Il migliore studio per tentare una soluzione a tale nodo critico, sarebbe quello longitudinale. Tuttavia in letteratura pochi sono stati gli studi di questo tipo (Wadsworth, 1979; Maughan et al., 1985; McGee et al., 1986), e con dati difficilmente comparabili fra loro data la varietà delle misure adottate.
Inoltre, anche le ricerche longitudinali comportano dei limiti evidenti, quali il perdere un quantitativo significativo di dati nel corso delle ricerche, oltre, la necessità di un ben maggior lasso di tempo per svolgere tali studi.
Date queste premesse, appare evidente che la ricerca non può e non vuole, discutere al riguardo della causa eziologica della comorbilità.
Lo scopo della ricerca consiste nell’esaminare quantitativamente le relazioni tra disabilità di lettura e comportamenti aggressivi, in un campione di 358 alunni fra i 7 e i 14 anni, di Carloforte.
A tal fine, ci si propone oltre al rilevamento dell’incidenza della dislessia nella popolazione scolastica delle scuole elementari e medie inferiori, della cittadina, di verificare il grado di comorbilità fra disturbo di lettura e valenze aggressive.
L’obbiettivo di condurre a Carloforte tale analisi di tipo epidemiologico, deriva dal fatto che la cittadina è sospettata di possedere, delle caratteristiche peculiari, dovute ad un retroterra genetico e culturale diverso, rispetto alla globalità della Sardegna.
La condizione d’insularità, fanno si che la maggior parte dei matrimoni, avvenga ancora tra concittadini, spesso legati da lontani rapporti di parentela.
Tale caratteristica permette alla popolazione, di mantenere un patrimonio genetico proprio, ma anche di far perdurare nel tempo caratteristiche dialettali, tradizionali, culturali, derivanti dalla sua storia di antica colonia ligure e che ovviamente, regolano ogni rapporto, primo fra tutti quello educativo-formativo tra vecchie e nuove generazioni.
A tal fine si sono individuati i soggetti appartenenti ad una fascia di età fra i 7 e i 14 anni, a cui sottoporre i test Sartori e Faglioni, per l’individuazione della dislessia, in modo da verificare l’ipotesi di una diversa epidemiologia del disturbo nella cittadina sarda.
Ciò tenendo conto che stime recenti, dimostrano che il 5% dei bambini italiani (5,1% nella popolazione sarda), di cui 3 su 4 maschi, possiede tale difficoltà di apprendimento.
L’ipotesi che la popolazione scolastica di Carloforte a causa di tali particolarità, possieda delle caratteristiche diverse, non dovrà fermarsi alle sole valutazioni epidemiologiche sulla dislessia.
Una volta verificata l’incidenza del disturbo specifico di lettura, si procederà al secondo momento della ricerca, che si proporrà di esaminare il grado di comorbilità fra dislessia e aggressività, seguendo gli studi citati nei precedenti capitoli del nostro lavoro.
Metodologia
Campione
Il campione è costituito da 12 classi della Scuola Elementare dalla 2°alla 5°, e da 9 classi della Scuola Media Inferiore dalla 1° alla 3°, per un totale di 194 alunni della scuola Elementare e 164 alunni della scuola Media.
Complessivamente dunque, il campione è di 358 alunni.
Le due Scuole sono all’interno del comune di Carloforte, scelto perché sospettato di possedere peculiarità che nel corso della ricerca abbiamo potuto evidenziare.
Le classi 1° della Scuola Elementare, sono state escluse dalla ricerca, perché le prove proposte non erano corrispondenti alla loro età e grado di scolarizzazione.
Le classi che si sono coinvolte nella ricerca sono state scelte per studiare l’evoluzione dei disturbi in oggetto.
Difatti l’acquisizione delle strumentalità di lettura come dimostra il modello di Uta Frith, proposto nella prima parte del lavoro, attraversa degli stadi di automatizzazione dei processi, così come le relative difficoltà di lettura.
Inoltre, lo studio dei disturbi comportamentali ha dimostrato come, a seconda dell’età del soggetto esaminato, gli atteggiamenti aggressivi abbiano caratteristiche differenti.
Criteri diagnostici
Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti con difficoltà dell’apprendimento della lettura si è fatto riferimento ai criteri diagnostici riportati nel ICD-10 e nel DSM-IV, i quali indicano i seguenti aspetti.
-
Criterio della discrepanza: si sono esclusi i soggetti che riportavano un QI significativamente al di sotto della prestazione media dei soggetti (al di sotto di un valore pari o superiore ad una deviazione standard). Questo perché, come già sottolineato in precedenza, si può parlare di disturbo specifico di lettura, se esiste una differenza significativa tra la prestazione al test cognitivo e la performance nell’abilità di lettura.
Per ciò che concerne la prestazione nella performance di lettura, si sono considerate significative, le prestazioni inferiori alla media del campione totale, in modo pari o superiore a due deviazioni standard. Fanno eccezione per la scuola Elementare le classi 2°. Data l’età dei soggetti e il grado di scolarizzazione, si è ritenuto opportuno considerare una deviazione standard.
A riguardo delle valenze aggressive, si è proceduto in modo analogo considerando, però, significative le prestazioni superiori alla media del campione totale, in modo pari o superiore a due deviazioni standard.
-
È bene sottolineare il fatto che trattandosi di un’indagine epidemiologica, non si è potuto prendere in considerazione vari fattori di esclusione, se non mediante un breve questionario informativo rivolto ai genitori dei soggetti testati, nel quale si chiedeva di intervenire a proposito di alcuni criteri quali: la possibile ereditarietà del disturbo di lettura, eventuali traumi perinatali o postnatali del bambino, alcune considerazioni generali su eventuali problemi comportamentali.
Trattandosi di uno strumento consegnato alla famiglia (in completo anonimato), non si può considerarlo una misura sufficiente di esclusione di eventuali danni acquisiti durante lo sviluppo, né una controparte pienamente oggettiva, delle prove da noi sottoposte ai bambini.
Strumenti utilizzati
Gli strumenti diagnostici utilizzati, sono nel contempo: economici, sensibili, individuali, e adatti ad una vasta gamma d'età.
- Economici: la vastità del campione richiedeva che potessero essere somministrati dei test collettivi, che dovevano svolgersi in un lasso di tempo ristretto. Ciò garantiva una più precisa comparabilità tra i soggetti, soprattutto tra quelli della stessa età, poiché venivano esaminati in un periodo scolastico identico;
- Sensibili e specifici: l'indagine doveva consentire l'esatta individuazione del disturbo;
- Individualizzati: data la specificità della ricerca, le prove dovevano avvicinarsi il più possibile al singolo soggetto, per escludere eventuali errori diagnostici derivanti da vizi nello svolgimento delle prove collettive, come ad esempio copiature, suggerimenti, distrazioni;
- Adatti ad una vasta gamma di età: il campione abbraccia soggetti di età molto diverse, dai 7 anni per le classi 2° Elementare, ai 14 anni per le classi 3° Media, per questo si è provveduto all'utilizzazione di prove che consentissero una diversificazione e comparazione dei risultati, tenendo conto del grado di competenza posseduto dai soggetti e di altre variabili date dalla diversità di età.
Test collettivi
a) Test cognitivo: Culture Free Scala 2 Forma A Cattel.
La prova d'Intelligenza Aculturale di Cattel è uno strumento carta-matita, a tempo, suddiviso in 4 sub-test:
- Il primo è il sub-test della SERIE:
Vengono proposte delle serie di immagini da ultimare con una scelta fra 5 proposte.
E' composto da 12 items, da svolgersi entro 3 minuti. - Il secondo è il sub-test della CLASSIFICAZIONE:
Vengono proposte 5 figure delle quali una è da indicare come non corrispondente a questa classificazione, poiché non ne fa parte logicamente.
E' composto da 14 items, da svolgersi in 4 minuti. - Il terzo è il sub-test con le MATRICI:
Vengono presentati degli insiemi di 3 disegni da completare, scegliendo fra 5 proposti, il disegno che più si adatta al contesto già strutturato.
Il sub-test è composto da 12 items, da risolversi in 3 minuti. - Il quarto è il sub-test delle CONDIZIONI:
Vengono proposte 5 immagini, fra le quali scegliere quella che possiede le stesse condizioni del modello standard.
E' composto da 8 items, da risolvere in 4 minuti.
La somministrazione del test, di tipo collettivo, richiede la spiegazione di ogni sub-test, attraverso degli esempi che vanno completati insieme alla somministratrice, così che si possa verificare l'avvenuta comprensione della prova.
Per questo motivo, in relazione all'età e alla classe scolastica, la somministrazione del test abbisogna di un minimo di 30 minuti (in genere nelle classi 3° Media), ad un massimo di circa 1 ora (ad esempio nelle classi 2° e 3° Elementare).
Il test ha come finalità, quella di verificare il livello intellettivo dei soggetti, di là del diverso grado di scolarizzazione.
E' uno strumento fondamentale per la nostra ricerca, perché ci permettere di escludere da un'eventuale diagnosi di dislessia, quei soggetti con prestazioni al di sotto alla norma.
b) Test di lettura:
- Prova di riconoscimento di parole TRP.
- Prova di riconoscimento di parole senza significato TRPS (FAGLIONI et al. 1967)
La prova Faglioni è uno strumento carta-matita a tempo.
E' suddivisa in due sub-test:
La prima prova consta di 50 items.
In ognuno di questi, viene proposta una definizione da completare con una parola scelta fra 5 proposte. Ogni definizione al suo interno, ha una parola sottolineata nei confronti della quale si vuole attirare l'attenzione del soggetto.
Il vocabolo scelto per completare la definizione, deve essere solo segnato con una crocetta, senza dover essere riscritto.
Il test ha una durata massima complessiva di 10 minuti, allo scadere dei quali, è definitivamente interrotta la prova.
Ogni minuto, veniva dato uno stop ai soggetti, i quali dovevano segnare tramite una crocetta il numero dell'item completato fino a quel momento, per poi ripartire insieme, al nuovo via dato dalla somministratrice.
La seconda prova prevede anch'essa 50 items.
Ogni items consta di una parola senza significato presa come modello e per questo sottolineata. Al suo fianco si trovano altre 4 parole senza significato, di cui solo una e' identica al modello.
Il soggetto doveva segnare con una crocetta quale fosse, a suo parere, la parola identica a quella sottolineata.
Questo secondo test, è stato proposto anch'esso, come prova a tempo. I soggetti, ogni minuto erano invitati ad interrompere il lavoro ed indicare l'ultimo items completato, con una crocetta sul numero ad esso corrispondente.
Immediatamente dopo, procedevano a completare gli items mancanti fino allo scadere del tempo concessogli (10 minuti).
La somministrazione del test, richiede una spiegazione dei due sub-test e di alcuni esempi per verificare che si sia compreso il meccanismo di svolgimento.
I soggetti erano invitati dalle somministratrici a completare le prove mediante una lettura silente.
Per quanto riguarda la Scuola Elementare, per le classi 2° il test ha avuto bisogno d'alcuni miglioramenti.
Dal punto di vista grafico, si è provveduto a stampare le stesse prove con caratteri più grandi rispetto a quelli usati per gli altri alunni, poiché tenendo conto del grado di scolarizzazione di questi alunni, l'utilizzo di caratteri piccoli avrebbe creato una difficoltà ulteriore, che ovviamente poteva alterare la valutazione della prova.
Dal punto di vista dell'attenzione, si è provveduto a porgere il test come una gara dove era importante far vedere dove si era arrivati ad ogni minuto. Per questo ci si è premuniti di ricordare ogni volta di segnare l'item completato per ultimo, e si e controllato che tutti ricominciassero la lettura nello stesso momento.
Test individuali
a) Test Sartori:
- Lettura di parole
- Lettura di parole senza significato
Il test Sartori è uno strumento carta-matita, composto da due prove:
- La prima che viene identificata come la 4° prova nella Batteria per la valutazione della Dislessia e della Disortografia Evolutiva di G. Sartori, R.Job, P.E. Tressoldi, consta nel leggere a voce alta quattro liste di 28 parole ciascuna. Ogni lista ha un gradiente diverso di difficoltà.
- La seconda prova è quella di lettura di non parole, ossia di termini che non hanno significato nella lingua italiana. E' questa la prova n° 5 della suddetta batteria di test Sartori, e prevede la lettura ad alta voce di 3 liste, anch'esse un gradiente di difficoltà crescente, ognuna composta da 16 parole.
Inizialmente il test è stato presentato alla classe come prova individuale e ne sono stati definiti i criteri di svolgimento.
Si è spiegato agli alunni, che si sarebbe trattato di una lettura veloce di singole parole scritte su un foglio esterno al fascicolo delle prove collettive di cui erano in possesso.
Tale foglio sarebbe stato consegnato ad ognuno, solo nel momento d'inizio della propria prova. In seguito a tale spiegazione, gli alunni sono stati invitati uno per volta in un ambiente esterno all'aula, atto alla somministrazione del test in forma individualizzata. Ogni bambino, ha avuto modo di familiarizzare, mediante un breve colloquio, con le somministratrici. Tale colloquio oltre ad essere utile direttamente ai fini della ricerca, in quanto si è tenuto conto di alcuni dati personali, quali: età, sesso, lateralità, è stato altrettanto necessario, per far si che la prova si svolgesse in maniera più distesa, in modo da attenuare la presenza di eventuali stimoli ansiogeni.
In questa fase si è cercato altresì un commento sulle difficoltà delle prove appena terminate e sulla vita di classe, in modo da poter capire meglio le caratteristiche del soggetto che si stava testando.
E' sempre in questo contesto che si è chiarita meglio la modalità di svolgimento della prova. Si è spiegato ai soggetti che dovevano leggere a voce ben chiara e velocemente una lista di parole. Al termine di tale lista prima di leggere la seconda colonna, dovevano fermarsi per dar modo alle somministratrici di appuntare il numero degli errori compiuti, e il tempo impiegato a leggere tutta la colonna.
Si è provveduto altresì a collocarsi frontalmente all'allievo spiegandogli che, per seguire la sua lettura si aveva a disposizione una copia speciale del foglio, sulla quale si sarebbero appuntate le parole lette in maniera errata, e un cronometro per misurare il tempo impiegato per la lettura di ogni lista. Per cui s'invitavano gli alunni, a prestare particolare attenzione al proprio foglio, senza preoccuparsi di seguire gli appunti presi dalla somministratrice durante la lettura.
Ai più curiosi, per evitare ogni distrazione, veniva promesso di verificare i propri errori a fine lettura.
La seconda parte del test veniva indicata come la continuazione della prova precedente, specificando però che questa volta si sarebbe trattato di leggere parole inesistenti.
La somministratrice durante tutto il corso della lettura, non doveva incoraggiare il lettore, né commentare eventuali errori, se non al termine di ogni lista.
Soprattutto per le 2° e 3° Elementari si è più volte concesso qualche istante di pausa fra una lista e l'altra, qualora il soggetto appariva disattento o affaticato.
Ogni volta che s'interrompeva la lettura, si girava il foglio di lettura in modo da evitare che il soggetto potesse leggere le parole successive.
b) Il Buss-Perry Aggression Questionnaire
Il Buss-Perry Aggression Questionnaire, o BPAQ, è uno strumento per la misurazione degli atteggiamenti aggressivi elaborato nel 1992, da Arnold H. Buss ed un suo collaboratore Mark Perry.
E' una versione aggiornata e migliorata del BDHI (Buss-Durkee Hostility Inventory), elaborato da Buss e Durkee nel 1957, un questionario più vasto e ampiamente accettato, ma che presentava, secondo gli stessi autori, vari limiti.
Nel BPAQ, solo alcuni items derivano dallo strumento originale, la maggior parte è stata riscritta per l'occasione. Un gran numero di affermazioni sono state eliminate, perché considerate ingannevoli, molte altre sono state riscritte al fine di apportare maggiore chiarezza alla loro comprensione.
E' uno strumento costituito da 29 items, suddivisi in quattro sottoscale: Aggressione fisica, Aggressione verbale, Rabbia, Ostilità.
Le risposte sono valutate in una forma di tipo Likert, con un punteggio 1-5, nell'intervallo tra Del tutto insolito per me a Molto tipico del mio agire.
Gli alunni sono stati invitati ad indicare quanto corrispondesse ogni affermazione al proprio carattere.
Per fare ciò il soggetto è stato invitato a segnare con una crocetta uno dei quattro gradi d'affinità con l'affermazione descritta.
Per ogni grado è stata utilizzata una lettera dell'alfabeto. Così:
- A corrisponde a PER NULLA;
- B corrisponde ad UN POCO;
- C corrisponde ad ABBASTANZA;
- D corrisponde a MOLTO.
La scelta di utilizzare le lettere dell'alfabeto invece che i numeri, nasce dalla riflessione che i soggetti testati avrebbero potuto scegliere sempre il grado 4, ritenendolo più importante rispetto agli altri.
La somministrazione del test, è stata preceduta da una semplice spiegazione, inoltre, i soggetti durante tutto il corso del questionario hanno potuto chiedere delucidazioni alle somministratrici a proposito delle affermazioni più oscure.
Soprattutto per le classi 2° della Scuola Elementare, il test è stato somministrato direttamente dalle testatrici, data l'astrattezza e la difficoltà espressiva di certe affermazioni.
I bambini più piccoli venivano aiutati tramite, esempi della vita quotidiana, atti a ricondurli al loro vissuto personale.
Questi interventi sono stati preparati prima della somministrazione, per evitare un'eccessiva improvvisazione che avrebbe potuto causare disparità nel corso della somministrazione del questionario.
Occorre esprimere una considerazione necessaria ai fini della corretta interpretazione dei risultati del test.
Il fatto che il BPAQ, sia uno strumento autoreferenziale, fa si che i soggetti, liberi di rispondere autonomamente alle domande, possano non esprimersi in modo totalmente sincero, o che comunque, non siano oggettivi nell'autovalutazione (si potrebbero giudicare diversamente rispetto a ciò che comunicano, fanno o manifestano agli altri).
L'indagine andrebbe dunque, confermata da altre inchieste rivolte ai genitori, agli amici, o agli insegnanti dei soggetti testati, che, in questa sede, non hanno ritenuto opportuno collaborare in modo manifesto ed ufficiale.
Questionario informativo rivolto ai genitori
Il questionario per i genitori, non è una prova vera e propria, ma piuttosto un questionario informativo utile per l'interpretazione delle prove degli alunni testati a scuola.
Esso è suddiviso in 4 parti, contenenti domande a risposta chiusa, salvo talune che prevedono alcune precisazioni.
1) La prima parte si riferisce sl padre del bambino testato e prevede:
- domande quali l'età, il titolo di studio, la professione;
- informazioni rispetto al periodo scolastico inerenti difficoltà di apprendimento o eventuali bocciature;
- notizie sulla famiglia d'origine rispetto ai DSA e a insuccesso scolastico
2) La seconda identica alla prima, si riferisce però alla madre.
3) La terza si riferisce al bambino osservato a scuola. Si compone di varie domande inerenti:
- opinioni rispetto la riuscita scolastica;
- varie informazioni sul periodo della gestazione o comunque dei primissimi anni di vita del soggetto;
- eventuali DSA osservati in famiglia;
- problemi comportamentali.
4) La quarta circa eventuali altri figli:
- quanti altri figli oltre il soggetto testato con relative delucidazioni sul sesso, l'età;
- informazioni rispetto difficoltà di apprendimento ed eventuali bocciature.
Consegnato il questionario, si è provveduto a spiegare le modalità di risposta da comunicare ai genitori, e si sono fornite brevi informazioni sulle finalità della ricerca. In alcuni casi inoltre, su richiesta degli stessi genitori, si sono chiariti alcuni dettagli sullo scopo dei test.
Il questionario è stato proposto ai soggetti come momento altrettanto importante della ricerca, per cui gli alunni si sono impegnati a riportarlo a scuola completato entro 3 giorni dalla consegna.
Vista la necessità di condurre la ricerca nel rispetto della privacy, si è identificato ogni questionario con un numero, in modo tale da poterlo associare al relativo fascicolo delle prove condotte a scuola, senza dover venir meno al diritto del soggetto all'anonimato.
La finalità del questionario, è rilevare considerazioni sui soggetti esaminati, riguardo a problemi comportamentali ed eventuali fattori di esclusione (es.traumi postnatali), oltre che conoscere meglio l'aspetto socioculturale, della famiglia, in modo da avere delle relative conferme sulle prove condotte a scuola.
Il fatto che all'interno del questionario esistano altre domande rivolte a riscontrare l'eventuale familiarità del disturbo, è giustificato dal fatto che la ricerca fa parte di uno studio più ampio, rivolto anche alla verifica della matrice genetica della dislessia.
Aspetti generali sulle caratteristiche del campione
La ricerca si poneva come primo obiettivo, quello di raccogliere dei dati circa l'incidenza della dislessia nella popolazione scolastica di Carloforte.
E' significativo il fatto che la percentuale dei dislessici individuata dopo l'esclusione delle classi 2° Elementari dal campione generale, per le motivazioni già esposte, corrisponde all'8% differenziandosi dai dati riportati nel DSM-IV (5%).
Esistono, in letteratura, risultati discrepanti da regione a regione: mentre Sicilia (6.3%), Calabria (6,7%), Toscana (6,7%) e Veneto (7.6%), si collocano intorno a valori medi, per la Puglia l'incidenza è notevolmente maggiore (13,3%) e per l'Abruzzo (3.3%) e il Piemonte (3.8%) l'incidenza è sensibilmente inferiore alla media. Ciò dipende dai fattori implicati e dalla struttura dello strumento utilizzato.
Il primo aspetto che si è reputato utile analizzare riguarda il rapporto maschi\femmine all'interno dei casi.
Tale variabile è stata presa in considerazione in quanto numerose indagini, compiute su soggetti con dislessia evolutiva, riportano una prevalenza di soggetti di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile. Il DSM-IV, per esempio, riporta che il 60-80% dei soggetti a cui viene diagnosticato un disturbo della lettura, sono maschi.
Il nostro campione rispecchia questi dati: il 56% dei dislessici sono maschi contro il 44% dei dislessici di sesso femminile (Fig.1).

La proporzione viene confermata anche se si prende in considerazione il campione totale distinto in base al sesso: difatti il 9.45% dei maschi è dislessico, contro il 6.87% delle femmine (Fig.2). Ciò rispecchia i dati delle ricerche sulle anomalie del substrato neuroanatomico, che dimostrano un'influenza del testosterone nella formazione dell'emisfero cerebrale sinistro.

Una seconda variabile considerata è quella relativa alla lateralità.
Dai dati ricavati si deduce una maggioranza di destrimani sia nel campione complessivo 88.6% (Fig.3), che tra la popolazione dei dislessici 88% (Fig. 4). Ciò non coincide con i dati ufficiali che invece, vedrebbero la dislessia più spesso correlata con il mancinismo.

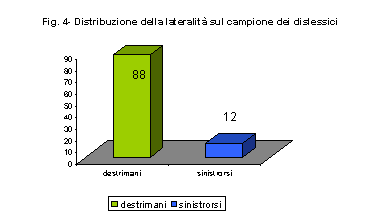
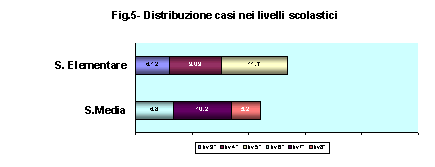 L'indagine ha inoltre, focalizzato l'attenzione sulle prove individuali di lettura, considerando i soggetti nelle diverse fasce scolastiche. Nella Fig. 5, si riportano le percentuali dei casi calcolate rispetto al numero totale dei singoli livelli.
L'indagine ha inoltre, focalizzato l'attenzione sulle prove individuali di lettura, considerando i soggetti nelle diverse fasce scolastiche. Nella Fig. 5, si riportano le percentuali dei casi calcolate rispetto al numero totale dei singoli livelli.
Si osservi come per la scuola elementare le classi 5°, hanno una percentuale di casi, maggiore rispetto alle altre. Nella scuola Media il valore più elevato dei casi è nelle classi seconde.
 Nell'analisi dei risultati del test Sartori, è stata rilevata una prevalenza di casi nelle prove 4E, 5E denotando una maggiore inclinazione a commettere errori piuttosto che a leggere lentamente (Fig. 6).
Nell'analisi dei risultati del test Sartori, è stata rilevata una prevalenza di casi nelle prove 4E, 5E denotando una maggiore inclinazione a commettere errori piuttosto che a leggere lentamente (Fig. 6).
Per la Lingua Italiana, il primo studio sull'evoluzione della letto-scrittura, è stato il lavoro di Tressoldi del 1995. Dai dati ricavati, il ricercatore afferma che anche per l'italiano esiste un'evoluzione dalla fase alfabetica a quella lessicale, come dimostrato da U. Frith per la lingua inglese. Quest'ultima sembra si sviluppi successivamente e in modo graduale rispetto a quella alfabetica.
Analizzando i dati da lui ottenuti e confrontandoli con la nostra indagine, troviamo però delle discrepanze.
 Tressoldi, ad esempio, osserva che il tempo occorso ai soggetti testati per la lettura di parole è sempre minore a quello occorso per la lettura di non parole, così come inferiori sono gli errori commessi nella lettura delle prime rispetto alle seconde, dimostrando una sensibilità al contesto.
Tressoldi, ad esempio, osserva che il tempo occorso ai soggetti testati per la lettura di parole è sempre minore a quello occorso per la lettura di non parole, così come inferiori sono gli errori commessi nella lettura delle prime rispetto alle seconde, dimostrando una sensibilità al contesto.
Nei nostri risultati (Fig.7), si evidenzia un netto equilibrio di casi rilevati nelle prove concernenti le parole e le non parole.
Correlazioni tra dislessia ed aggressività
Dopo aver commentato i risultati sulla parte epidemiologica del nostro studio sulla dislessia, procediamo all'analisi delle correlazioni tra disturbo della lettura e valenze aggressive.
Abbiamo avuto modo di esporre nei capitoli precedenti vari, studi sulla comorbilità fra i disturbi specifici dell'apprendimento e i comportamenti aggressivi.
La necessità di esaminare questo particolare aspetto della dislessia, parte dalle considerazioni che vari autori fanno a proposito dello svantaggio sociale derivante da questa comorbilità.
Ackerman e Dykman, in particolare, si distinguono per la loro attenzione nei confronti della comorbilità fra dislessia e disturbi comportamentali. Questa combinazione, affermano i ricercatori, sembra esporre i bambini al rischio di una sociopatia da adulti, più di quanto non facciano i soli disturbi dell'apprendimento.
Sheila Williams e Rob McGee nel 1994, in uno studio su 698 bambini dimostrarono che la difficoltà di lettura riscontrata a 9 anni, era un buon predittore, di comportamenti antisociali e di delinquenza giovanile nell'età adolescenziale.
Si è già evidenziato inoltre, come esista un divario fra l'analisi sul campo da parte di insegnanti, psicologi, personale della giustizia minorile, che osservano con continuità, la comorbilità fra i due disturbi, e, gli studi che invece non riportano con la stessa evidenza questo legame.
Ciò è dovuto probabilmente al fatto che, diverse sono le misure utilizzate per queste ricerche e quindi, la comparazione degli studi si presenta problematica.
Il compito della nostra indagine, è quello dell'analisi epidemiologica di tale comorbilità, in una popolazione particolare come abbiamo visto essere quella di Carloforte, in modo da verificare se esista una relazione tra dislessia e aggressività, nel nostro campione.
Perciò in primo luogo, procederemo ad esaminare i grafici che evidenziano la distribuzione dei casi con valenze aggressive nelle diverse sottoscale del Test.
Il BPAQ, difatti si compone di 29 items che intendono identificare, 4 diversi tipi di caratteristiche aggressive, "l'ostilità", "la rabbia", "l'aggressività verbale", "l'aggressività fisica".
Nel nostro campione esiste una tendenza all'incremento dei casi in modo proporzionale all'aumentare dell'età dei soggetti. Difatti, al contrario degli altri livelli nelle Classi 1° e 3° della Scuola Media, abbiamo rilevato dei casi in ogni sottoscala del Test (Graf.1).
 Inoltre, possiamo notare come in ogni livello, siano presenti casi con "aggressività fisica", mentre nelle fasce d'età più giovani, non compaiono soggetti con "ostilità".
Inoltre, possiamo notare come in ogni livello, siano presenti casi con "aggressività fisica", mentre nelle fasce d'età più giovani, non compaiono soggetti con "ostilità".
Il Graf.2, evidenza la distribuzione dei casi, identificati con l'utilizzo di un cut off unico, nei due sessi.
Si osservi come la maggioranza dei soggetti frequenti le Classi 1° della Scuola Media.
Inoltre, per la maggior parte dei livelli scolastici, il sesso maschile è predominante.
Questo confermerebbe i dati di numerose indagini (Rutter et al., Ackerman & Dykman).
 Utilizzando un cut off proprio per i due sessi, si sono rilevati: l'11,49% dei casi nel campione complessivo dei maschi, mentre nel campione delle femmine abbiamo il 10% (Graf. 4-5).
Utilizzando un cut off proprio per i due sessi, si sono rilevati: l'11,49% dei casi nel campione complessivo dei maschi, mentre nel campione delle femmine abbiamo il 10% (Graf. 4-5).
Ciò dimostra che utilizzando una misura specifica, i casi si equivalgono nei due sessi, evidenziando i soggetti più aggressivi in ciascun campione.
 |
 |
Nel Graf.4, si può dunque osservare che, così come per i casi di dislessia, anche per i soggetti aggressivi, sia nella Scuola Elementare che nella Scuola Media, il sesso con più alta percentuale di casi sia quello maschile.  Conoscendo la distribuzione dei casi aggressivi e utilizzando i dati relativi ai soggetti dislessici osserviamo nei seguenti grafici le relazioni fra i due disturbi nel nostro campione.
Conoscendo la distribuzione dei casi aggressivi e utilizzando i dati relativi ai soggetti dislessici osserviamo nei seguenti grafici le relazioni fra i due disturbi nel nostro campione.
Come abbiamo già evidenziato nella Tab. 34, solo il 9% dei soggetti aggressivi sono dislessici (Graf.5).
 Nel Graf.6, il rapporto dislessia aggressività, calcolato sul totale dei soggetti dislessici, evidenza una percentuale ben più alta di non aggressivi.
Nel Graf.6, il rapporto dislessia aggressività, calcolato sul totale dei soggetti dislessici, evidenza una percentuale ben più alta di non aggressivi.  Ma se mettiamo a confronto la percentuale dei casi aggressi nei due campioni (dislessici e non dislessici), possiamo notare una propensione dei soggetti dislessici alle valenze aggressive lievemente maggiore rispetto ai soggetti non dislessici (Graf. 7).
Ma se mettiamo a confronto la percentuale dei casi aggressi nei due campioni (dislessici e non dislessici), possiamo notare una propensione dei soggetti dislessici alle valenze aggressive lievemente maggiore rispetto ai soggetti non dislessici (Graf. 7).  La nostra ricerca, quindi, non evidenza una netta prevalenza di soggetti aggressivi nel campione dei dislessici, tuttavia vi è una tendenza ai comportamenti aggressivi, maggiore tra i soggetti dislessici piuttosto che fra quelli non dislessici.
La nostra ricerca, quindi, non evidenza una netta prevalenza di soggetti aggressivi nel campione dei dislessici, tuttavia vi è una tendenza ai comportamenti aggressivi, maggiore tra i soggetti dislessici piuttosto che fra quelli non dislessici.
Conclusioni
Dall'indagine si è potuto ottenere come previsto, la verifica di un'incidenza della dislessia nella popolazione scolastica di Carloforte (8%), differente rispetto alle percentuali (5,1%) rilevate nel resto della Sardegna (1) (Masala e al., 1998).
Oltre, a questa indagine epidemiologica, si è potuto anche osservare, come rilevato dalle ricerche ufficiali, una percentuale maggiore di casi, nel sesso maschile.
Abbiamo inoltre, osservato che le difficoltà più cospicue, sono a riguardo della correttezza, piuttosto che dalla velocità della lettura.
Ma l'aspetto più importante che ci siamo prefissi di testare, è la correlazione fra dislessia e aggressività, che nelle ricerche trattate nei capitoli precedenti, appare un nodo fondamentale per il futuro degli studi sulla dislessia, soprattutto per ciò che riguarda la necessità di più precoci ed efficaci trattamenti riabilitativi, per limitare i danni derivanti da quello che Stanovich (1986) definisce come, pattern di povertà che sembrerebbe essere un povero che diventa sempre più povero.
I dati ricavati dall'indagine, ovviamente, non possono avere, date le caratteristiche degli strumenti utilizzati, un valore diagnostico per i due disturbi, tuttavia, il loro utilizzo può essere utile nell'individuare situazioni a rischio che potrebbero evolversi una volta al di fuori del circuito scolastico, in valenze comportamentali devianti problematiche, sia per l'individuo che per la società.
Note
1. Percentuale ottenuta in uno studio recente che ha utilizzato uno strumento diverso (test Faglioni), da quello da noi valutato per l'indagine.
Bibliografia
- Aaron P.G., Phillips S., Larsen S., Specific reading disability in historically famous persons, in Journal Learning Disabilities, 21, pagg. 523-538, 1988
- Achenbach T.M., Edelbrock C.S., Manual for the child behavior checklist and revised child behavior profile, New York: Queen City Printers, 1983
- Ackerman P.T., Dykman R.A., Gardner M.Y., Counting rate, naming rate, phonological sensitivity, and memory span: major factors in dyslexia, journal of learning disabilities, Vol.23, 5, pagg. 325-327, maggio 1990
- Ackerman P.T., Dykman R.A., Peters J.E., teenage status of hyperactive and non-hyperactive learning disabled boys, American Journal of Orthopsychiatry, 45, pagg. 577-596, 1977a.
- Ackerman P.T., Dykman R.A., Prevalence of additional diagnoses in add and learning disabled children, Advances in Learning and Behavioral Disabilities, Volume 6, Pagg. 1-25, 1990.
- Ackerman P.T., McGrew M.J.,Dykman R.A., A profile of male and female applicants for a special college program for learning-disabled students, Journal of Clinical Psychology, 43, pagg. 67-78, 1987
- Ashman A.F., Conway R.N.F., Guida alla didattica metacognitiva nelle difficoltà di apprendimento, Erickson, Trento, 1991
- Bakker D.J, Hemispheric differences and reading strategies: two dyslexia, Cognition, 11, pagg. 185-199, 1979
- Bakker D.J., Vinke J., Effects of hemisphere-specific stimulation on brain activity and reading in dyslexics, Journal of Clinical and Experimantal Neuropsychology, 7, pagg. 505-525, 1985
- Bakwin H., Reading disability in Twins, Developmental Medicine and Child Neurology, 15, pagg. 184-187, 1973
- Bale P., Behaviour problems and the relationship to reading difficulty, Journal of Research in Reading, 4, pagg. 123-135, 1981.
- Barwick M.A., Siegel L.S., The incidence and nature of learning disabilities in homeless, runaway youths, Journal of Research on Adolescence, 1996
- Bereiter C., Engelmann S., Teaching disadvantaged children in the preschool, Engelwood Cliffs N.J., Prentice- Hall (1966); trad.it., Scuola per l’infanzia e svantaggio culturale. Una proposta didattica per l’educazione preelementare, Angeli, Milano, 1977
- Berkowitz L., Aggression: A social Psychological analysis, McGraw Hill, New York, 1962a
- Biemiller A., Siegel L.S., A Lonigutinal study of the effects of the Bridge Reading Program for children at risk for reading failure, submitted, 1995 Binder A., Juvenile delinquency, Annual Review of Psychology, 39, pagg.253-282, 1988.
Autore: Angela Maria Granara è laureata in Scienze dell'Educazione ed opera come educatrice presso i Servizi Sociali di Carloforte. Ha avuto esperienze come insegnante di sostegno a soggetti con difficoltà di apprendimento ed insegna nella scuola di base con incarichi a tempo determinato.
copyright © Educare.it - Anno II, Numero 9, Agosto 2002

