![]()
| Credits | Copyright | Privacy Policy |
 L’articolo nasce da una riflessione innescata da un corso di formazione rivolto a docenti della scuola dell’Infanzia. Si propone di considerare i campi di esperienza come ambiti informali di competenza da far interagire globalmente nella progettazione didattica, attraverso la programmazione di compiti autentici. La valutazione di tali esperienze didattiche deve valorizzare il processo di apprendimento, non solo il risultato finale, fino a cogliere elementi che consentono di valutare le competenze via via acquisite.
L’articolo nasce da una riflessione innescata da un corso di formazione rivolto a docenti della scuola dell’Infanzia. Si propone di considerare i campi di esperienza come ambiti informali di competenza da far interagire globalmente nella progettazione didattica, attraverso la programmazione di compiti autentici. La valutazione di tali esperienze didattiche deve valorizzare il processo di apprendimento, non solo il risultato finale, fino a cogliere elementi che consentono di valutare le competenze via via acquisite.
 Da diversi anni l'Unione Europea prende provvedimenti per incentivare lo sviluppo delle competenze digitali nei Paesi membri agendo soprattutto in ambito formativo. Si prevede che tra qualche anno tali competenze saranno richieste in quasi tutti i posti di lavoro. Vi sono però da parte delle università ancora grosse difficoltà nel trasmettere cultura digitale. Questo contributo analizza la situazione degli atenei italiani in materia di competenze digitali citando in particolare l'esempio del Se@, il Centro di Tecnologie per la Comunicazione, l'Innovazione e la Didattica a distanza dell'Università di Ferrara che, in un panorama nazionale poco roseo, rappresenta un buon esempio di integrazione tra formazione e tecnologie digitali.
Da diversi anni l'Unione Europea prende provvedimenti per incentivare lo sviluppo delle competenze digitali nei Paesi membri agendo soprattutto in ambito formativo. Si prevede che tra qualche anno tali competenze saranno richieste in quasi tutti i posti di lavoro. Vi sono però da parte delle università ancora grosse difficoltà nel trasmettere cultura digitale. Questo contributo analizza la situazione degli atenei italiani in materia di competenze digitali citando in particolare l'esempio del Se@, il Centro di Tecnologie per la Comunicazione, l'Innovazione e la Didattica a distanza dell'Università di Ferrara che, in un panorama nazionale poco roseo, rappresenta un buon esempio di integrazione tra formazione e tecnologie digitali.
For several years now, European Union has been taking measures to subsidize the development of digital competence in Europe, acting especially in educational contexts. Today digital competence is a much sought-after competence and it is expected that in a few years most jobs will request it. But University has still today difficulty in transmitting it. This review aims to analyse the current situation of digital culture in Italian universities mentioning the example of Se@ at the University of Ferrara: in a not very promising national context, the Se@ represents a bright example of integration of education and digital technologies.
 Che cosa significa essere adolescenti oggi? A quali criticità è esposta la famiglia con figli adolescenti nell’epoca attuale e nella specificità sociale e culturale delle moderne società complesse? L’articolo esplora in modo sintetico le caratteristiche dell’età adolescenziale e propone suggerimenti educativi per supportare la costruzione dell’identità e del progetto di vita.
Che cosa significa essere adolescenti oggi? A quali criticità è esposta la famiglia con figli adolescenti nell’epoca attuale e nella specificità sociale e culturale delle moderne società complesse? L’articolo esplora in modo sintetico le caratteristiche dell’età adolescenziale e propone suggerimenti educativi per supportare la costruzione dell’identità e del progetto di vita.
 In una società sempre più globalizzata, multiculturale e multietnica, ben rappresentata dalla eterogeneità delle aule scolastiche, è sempre più urgente una formazione degli studenti ad una visione più aperta ed interculturale del mondo, basata sull’empatia, la tolleranza e il rispetto delle diversità. L’articolo analizza le competenze interculturali, esaminando il modello delle 3 C e fornendo alcuni esempi da mettere in pratica nel contesto classe.
In una società sempre più globalizzata, multiculturale e multietnica, ben rappresentata dalla eterogeneità delle aule scolastiche, è sempre più urgente una formazione degli studenti ad una visione più aperta ed interculturale del mondo, basata sull’empatia, la tolleranza e il rispetto delle diversità. L’articolo analizza le competenze interculturali, esaminando il modello delle 3 C e fornendo alcuni esempi da mettere in pratica nel contesto classe.
 Molte ricerche hanno individuato le connessioni che esistono fra esperienze motorie e sviluppo del bambino nell’ambito percettivo, sociale e cognitivo. Gli infanti, ad esempio, che hanno una lateralizzazione marcata precoce avranno uno sviluppo cognitivo maggiore. Ancora, i bambini, che fra i 3 e i 5 mesi imparano più velocemente a stare seduti su di una superficie piana, apprenderanno più parole nel periodo fra i 10 e i 14 mesi, quando cominceranno a parlare. L’acquisizione della deambulazione autonoma implementa lo sviluppo sociale. Diverse ricerche hanno messo in evidenza che gli infanti, che gattonano o camminano, utilizzano più informazioni sociali nel dirigere le loro azioni rispetto a quelli che non possiedono ancora queste capacità.
Molte ricerche hanno individuato le connessioni che esistono fra esperienze motorie e sviluppo del bambino nell’ambito percettivo, sociale e cognitivo. Gli infanti, ad esempio, che hanno una lateralizzazione marcata precoce avranno uno sviluppo cognitivo maggiore. Ancora, i bambini, che fra i 3 e i 5 mesi imparano più velocemente a stare seduti su di una superficie piana, apprenderanno più parole nel periodo fra i 10 e i 14 mesi, quando cominceranno a parlare. L’acquisizione della deambulazione autonoma implementa lo sviluppo sociale. Diverse ricerche hanno messo in evidenza che gli infanti, che gattonano o camminano, utilizzano più informazioni sociali nel dirigere le loro azioni rispetto a quelli che non possiedono ancora queste capacità.
 Molte Scuole secondarie di secondo grado, dopo il riordino del 2010, hanno provato a cimentarsi con la didattica per le competenze, mantenendo però, di fatto, invariato il curricolo e le modalità di valutazione. Talvolta, in vista del colloquio multidisciplinare, si è fatto convergere verso lo stesso oggetto di studio le diverse discipline: un grosso fraintendimento che fa coincidere la didattica per le competenze con l’interdisciplinarità. La riforma dell’Esame di Stato può essere l’occasione giusta per riflettere sulle distinzioni necessarie tra saperi e conoscenza, che poi è la differenza che passa tra le scienze, in senso lato, e la conoscenza intesa come consapevolezza dei saperi, tra sapere scientifico e sapere umanistico, tra sapere e fare. Perché “umanesimo” non è studiare le lettere, ma tradurre gli studi, tutti gli studi, in atti umani. La letteratura, la storia dell’arte, ad esempio, sono l’attuazione del pensiero, della cultura, del sapere di un tempo dato in opere concrete. E la piccola rivoluzione può essere l’occasione giusta anche per riflettere su parole, e quindi su rappresentazioni, come disciplinarità, interdisciplinarità, multidisciplinarità, transdisciplinarità usate a volte come intercambiabili - ma che intercambiabili non sono - e sul loro rapporto con lo sviluppo delle competenze.
Molte Scuole secondarie di secondo grado, dopo il riordino del 2010, hanno provato a cimentarsi con la didattica per le competenze, mantenendo però, di fatto, invariato il curricolo e le modalità di valutazione. Talvolta, in vista del colloquio multidisciplinare, si è fatto convergere verso lo stesso oggetto di studio le diverse discipline: un grosso fraintendimento che fa coincidere la didattica per le competenze con l’interdisciplinarità. La riforma dell’Esame di Stato può essere l’occasione giusta per riflettere sulle distinzioni necessarie tra saperi e conoscenza, che poi è la differenza che passa tra le scienze, in senso lato, e la conoscenza intesa come consapevolezza dei saperi, tra sapere scientifico e sapere umanistico, tra sapere e fare. Perché “umanesimo” non è studiare le lettere, ma tradurre gli studi, tutti gli studi, in atti umani. La letteratura, la storia dell’arte, ad esempio, sono l’attuazione del pensiero, della cultura, del sapere di un tempo dato in opere concrete. E la piccola rivoluzione può essere l’occasione giusta anche per riflettere su parole, e quindi su rappresentazioni, come disciplinarità, interdisciplinarità, multidisciplinarità, transdisciplinarità usate a volte come intercambiabili - ma che intercambiabili non sono - e sul loro rapporto con lo sviluppo delle competenze.
Non è cambiando o ampliando gli oggetti dell’apprendimento che si sviluppano competenze, ma lo si fa pensando in modo diverso al soggetto che apprende, agli strumenti di cui ha bisogno per rapportarsi autonomamente allo studio e alla realtà in cui vive. Se, cioè, cambiano le modalità di lavoro, il tipo di prestazioni richieste e le situazioni in cui le si chiede, nonché il compito che si propone. Non solo apprendimento e restituzione, quindi, ma utilizzo autonomo, intenzionale e consapevole di quanto appreso.
 Secondo le classifiche del Pisa (Programma per la valutazione internazionale dell'allievo) le scuole finlandesi sono tra le migliori al mondo. Una recente inchiesta della BBC ha reso noto come il modello scolastico stia abbandonando progressivamente la tradizionale suddivisione disciplinare dei saperi per concentrarsi sulle competenze da far acquisire agli allievi. Si tratta di un tema con cui si sta confrontando anche la scuola italiana, anche se siamo ancora in una fase in cui prevale l'aspetto formale (la "certificazione") e non la revisione dell'impianto didattico e contenutistico.
Secondo le classifiche del Pisa (Programma per la valutazione internazionale dell'allievo) le scuole finlandesi sono tra le migliori al mondo. Una recente inchiesta della BBC ha reso noto come il modello scolastico stia abbandonando progressivamente la tradizionale suddivisione disciplinare dei saperi per concentrarsi sulle competenze da far acquisire agli allievi. Si tratta di un tema con cui si sta confrontando anche la scuola italiana, anche se siamo ancora in una fase in cui prevale l'aspetto formale (la "certificazione") e non la revisione dell'impianto didattico e contenutistico.
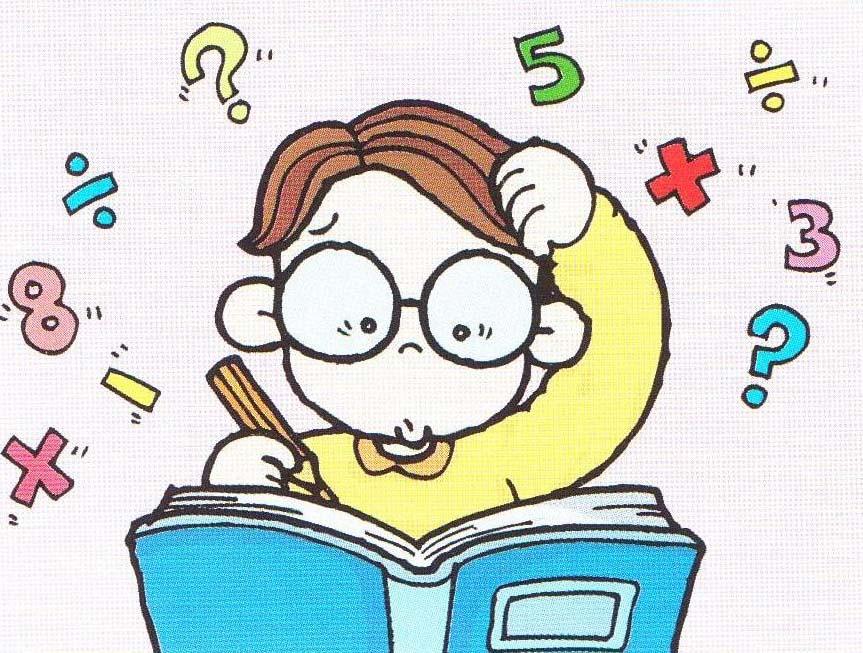 L’ansia relativa alla matematica si può definire come un’apprensione ed una paura che l’individuo sviluppa nei confronti della matematica. Livelli molto alti di ansia per la matematica hanno delle ripercussioni negative sulla vita quotidiana delle persone. Per esempio, possono far perdere delle opportunità lavorative.
L’ansia relativa alla matematica si può definire come un’apprensione ed una paura che l’individuo sviluppa nei confronti della matematica. Livelli molto alti di ansia per la matematica hanno delle ripercussioni negative sulla vita quotidiana delle persone. Per esempio, possono far perdere delle opportunità lavorative.
 A distanza di dodici anni dalle precedenti Raccomandazioni relative alle competenze chiave, il 22 Maggio 2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato le nuove Raccomandazioni relative alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, che hanno la funzione di stimolare gli Stati Membri a realizzare politiche nazionali di istruzione e formazione che siano più adeguate ai contesti sociali, economici e culturali contemporanei.
A distanza di dodici anni dalle precedenti Raccomandazioni relative alle competenze chiave, il 22 Maggio 2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato le nuove Raccomandazioni relative alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, che hanno la funzione di stimolare gli Stati Membri a realizzare politiche nazionali di istruzione e formazione che siano più adeguate ai contesti sociali, economici e culturali contemporanei.
 I costrutti cognitivi di presente, passato e futuro sono importanti per la contestualizzazione temporale delle esperienze. Per i bambini apprendere tali concetti astratti non è affatto semplice: per imparare la suddivisione del tempo nelle tre dimensioni, è fondamentale che si padroneggi prioritariamente il concetto di tempo, inteso come una variabile che connota le esperienze. Le ricerche relative all’acquisizione della dimensione temporale, in psicologia infantile, sono correlate agli studi fatti nell’ambito dello sviluppo linguistico e cognitivo.
I costrutti cognitivi di presente, passato e futuro sono importanti per la contestualizzazione temporale delle esperienze. Per i bambini apprendere tali concetti astratti non è affatto semplice: per imparare la suddivisione del tempo nelle tre dimensioni, è fondamentale che si padroneggi prioritariamente il concetto di tempo, inteso come una variabile che connota le esperienze. Le ricerche relative all’acquisizione della dimensione temporale, in psicologia infantile, sono correlate agli studi fatti nell’ambito dello sviluppo linguistico e cognitivo.
Per spiegare al bambino i costrutti temporali, è necessario che egli sappia parlare e, soprattutto, sia capace di intendere quello che viene detto dagli adulti. In pratica, deve possedere la competenza linguistica sia espressiva che ricettiva per capire a fondo la temporalità.
![]()
| Credits | Copyright | Privacy Policy |
